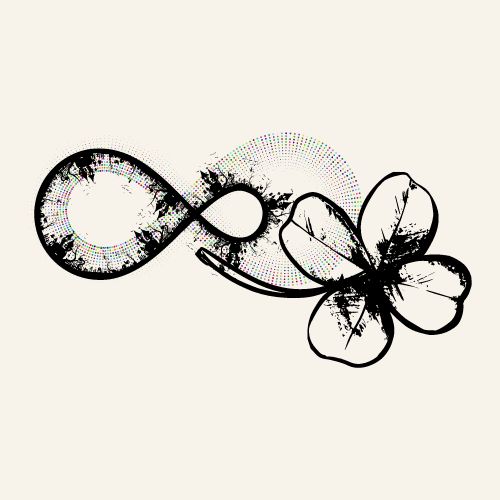Mi è stato chiesto di partecipare ad un podcast in cui si parla della morte in tono ironico. La notizia non sta nel fatto che mi sia stato chiesto di partecipare al podcast. La notizia è il parlare della morte in modo social.
Un mondo nuovo per me quello dei podcast. Sono sempre stata restia a mettere in campo la mia voce. E delle mie emozioni mi è sempre sembrato più spontaneo parlarne e affidarle alle parole scritte.
Però capita che ci si metta in gioco. Capita che si provi a fare un qualcosa di nuovo, con persone nuove. Così è nata questa conversazione sulla morte e i suoi aspetti più ironici, partendo ovviamente da quelli meno goliardici.
Mi sono riscoperta a parlare dei miei gatti e della morte di uno di loro. A immaginare dove poter essere dopo avendone già un’idea da tempo, depositata a chi mi è più caro. Ho parlato della morte e delle tombe del futuro, scivolando come sempre nel lato più social della questione.
E qui mi soffermerei per un momento. Stabiliamo da sempre dei canoni che affidiamo alla comunicazione post mortem. Dall’immagine alle condoglianze che, spesso – purtroppo molto spesso – si trasformano in silenzio quando sarebbe il caso di dare voce alle parole. Ecco, non ci si sa comportare, diciamola tutta. Il prima si arricchisce di discorsi senza senso, trascinati nei complessi meandri dell’andrà tutto. Si cerca di dare forza ad una circostanza imponderabile, senza crederci, senza convinzione. Dopo ci si nasconde nel “non sapevo cosa dire“, quando anche un abbraccio o un’icona su un messaggio si rivelano molto più utili di frasi fatte o di silenzi che nutrono solitudine.
Ho meditato sulla morte sui social network. Partendo dallo spunto di una domanda, ho pensato a quella valanga di immagini che invadono le nostre gallery degli smartphone. E poi, una di quelle affidata al popolo del web con gli immancabili “buon ponte” di rito. Ecco. Quel ponte, probabilmente, serve più a noi che al nostro animale domestico. Quel ponte, infatti, è l’unico legame che ci permette di tornare indietro dal dolore più assoluto. Ma quale effettivo benessere riceviamo dai commenti e dai like di amici lontani o di conoscenti che quel cane o quel gatto hanno mai visto? O che non hanno mai conosciuto la persona cara che ci ha sprofondato nella ricerca del conforto social?
Si dice che il Like sia una sorta di dipendenza narcisistica che cerca approvazione negli altri. Io aggiungerei che non meno di una foto di una mangiata in riva al mare, la ricerca del Like o del commento (non) spontaneo sia un palliativo al nostro dolore. Un modo per allontanare il momento dell’imponderabile e spogliarlo dell’alone di mestizia che gli è proprio. Nasce così un’esorcizzazione del proprio malessere che si cerca negli estranei. Il commento o le parole di sostegno dovrebbero giungere non richieste da chi ha vissuto con noi tutto il pellegrinaggio verso la fine. Fino al silenzio.
E qui concludo. Se dovessi pensare ad una parola che più di altre assocerei alla morte è proprio silenzio. E non il vuoto come si potrebbe credere. Il vuoto è di per sé incostante ma allo stesso tempo immutabile. Il silenzio ha un suo peso. Proprio come quello delle parole. Che ci siano o meno. Non importa dove. Non importa come. Non importa se spontanee o richieste. Il silenzio si dirama nell’ambivalente compagno del dolore che prende le sembianze di chi abbiamo perso e di chi potrebbe esserci. Ma, di fatto, non c’è.